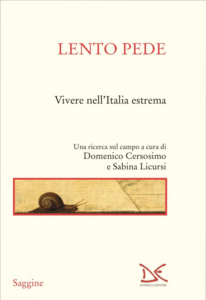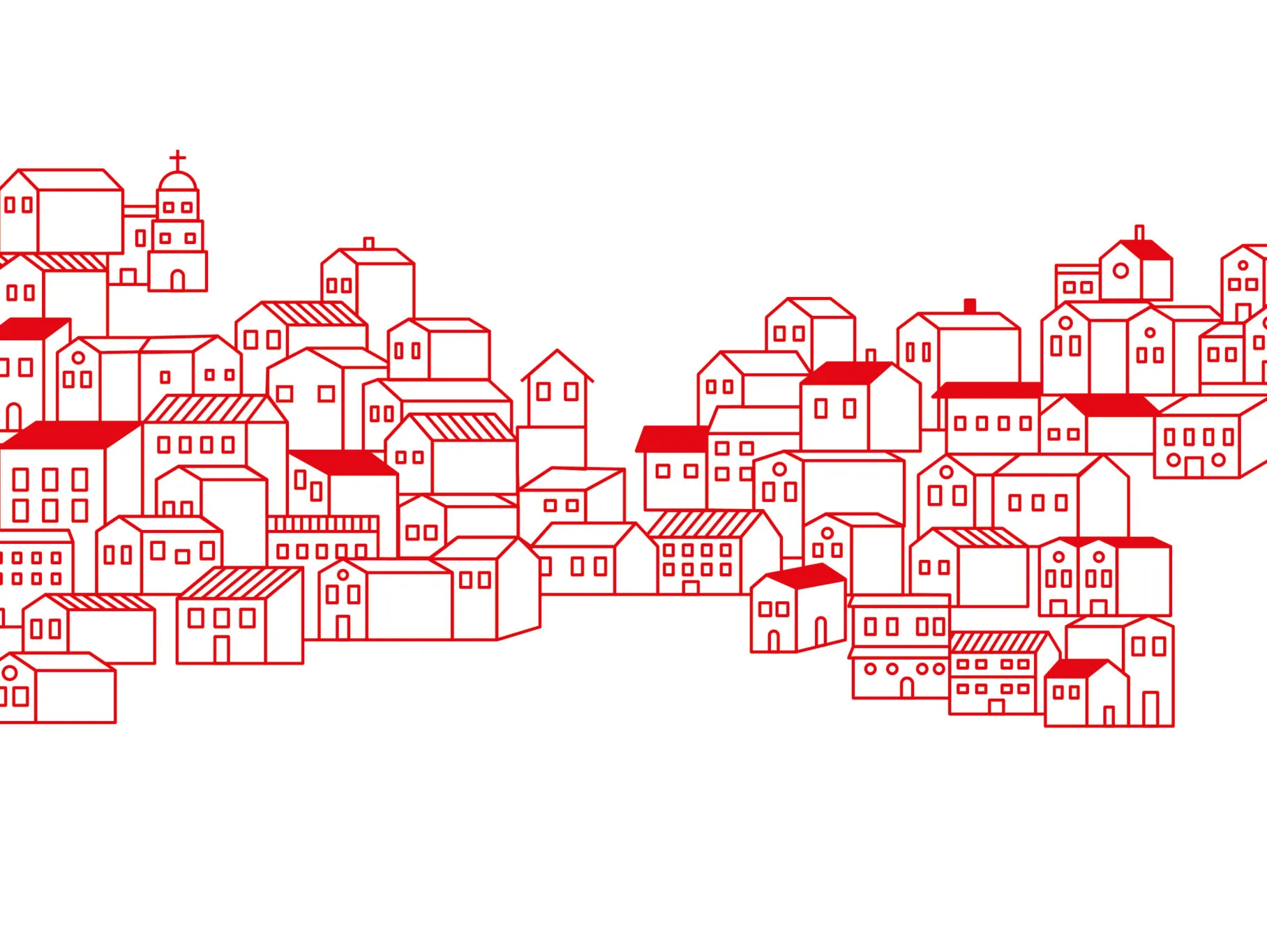
Le letture consigliate del mese di novembre
1) Le Piazze vuote, Filippo Barbera
Filippo Barbera è Professore Ordinario di Sociologia Economica presso il Dipartimento CPS dell’Università di Torino, dove insegna Teoria sociale applicata, Sviluppo locale e Innovazione sociale. Si occupa di innovazione sociale, economia fondamentale e sviluppo delle aree marginali. Tra le sue recenti pubblicazioni, ricordiamo: Innovatori sociali, Bologna, Il Mulino, 2019 (con Tania Parisi) e Economia Fondamentale, Torino, Einaudi, 2019 (come “Collettivo per l’economia fondamentale”). Ha partecipato al progetto editoriale “Riabitare l’Italia”, pubblicato da Donzelli, 2018 (a cura di Antonio De Rossi). È membro del Forum Diseguaglianze e Diversità e affiliate presso il Collegio Carlo Alberto (Torino) e componente il Comitato Scientifico di Cramars soc. coop.
In molti Paesi europei le piazze sono piene, le strade invase e lo spazio pubblico è un rituale che crea effervescenza collettiva, solidarietà, capacità di futuro. In Francia, la riforma delle pensioni voluta dal Presidente Macron ha scatenato una massiccia ondata di proteste. Le piazze sono piene, le strade invase, lo spazio pubblico è un grande rituale che crea effervescenza collettiva, solidarietà, identità. La reazione delle piazze francesi è dovuta a due elementi cruciali, assenti in Italia. Il primo riguarda l’incapacità di reazione alle violazioni della cosiddetta «economia morale». Con questo concetto, lo storico E.P. Thompson, nel suo lavoro sulle rivolte inglesi del 18° secolo, spiegò le azioni di protesta collettiva circa la distribuzione di generi di prima necessità andando oltre gli interessi materiali. Oltre a questi, che svolgevano certamente un ruolo, la veemenza e la pervasività delle proteste erano da ricondurre alle violazioni da parte delle élite dei loro obblighi verso la collettività. Contava quindi il senso di giustizia verso tali obblighi e il senso morale che pervadeva la vita quotidiana delle classi popolari. Una situazione impensabile in Italia, dove le pratiche associative e la partecipazione sociale non alimentano più il circuito della rappresentanza politica. La domanda di futuro rimane drammaticamente separata dalla sua offerta. La chiusura nel presente alimenta una politica della paura e della rabbia, dove conta la distanza guadagnata da chi è più debole. Occorre ricostruire la capacità collettiva di futuro nei diritti di cittadinanza, nella rappresentanza politica e nel governo dei luoghi di vita e di lavoro. Occorre fare spazio alla politica per dare voce a chi ha meno potere. Solo in questo modo i bisogni individuali diventano soluzioni universalistiche, generative di nuove forme dell’agire in comune. Filippo Barbera ricorda, nello specifico, che vi sono una serie di motivi che sostengono la crescente narcotizzazione sociale in cui è immerso il popolo italiano. In primo luogo, gli italiani hanno sempre avuto bisogno di un motore organizzato, di un partito o movimento che sapesse condurli in piazza e sostenesse un senso comunitario dei diritti. Noi italiani – sostiene Barbera – abbiamo bisogno dell’intermediazione politica e sindacale. Ed è questa che oggi è assente e nessuno chiama più alla piazza. Lo studioso riflette sul fatto che manca la reputazione, manca la fiducia in una leadership e, poi, nella società si fa strada un atteggiamento sempre più disponibile verso il potere. In questo senso ci si trova di fronte a fenomeni nuovi: le comunità prima ancora di indignarsi per diritti negati o per una promessa non mantenuta o in considerazione che nessuno si occupa di problemi concreti, e su questi elementi adoperarsi per aprire un conflitto sociale, chiedono il permesso di sostituirsi allo Stato inadempiente, nella sottomissione più plateale, richiedono cioè di fare delle cose al posto dell’autorità che non adempie alle proprie funzioni. In particolare, gli strati più deboli della società anche quando vedono contrarsi servizi, prestazioni, sussidi anziché promuovere una contestazione, come sarebbe logico immaginarsi, declinano verso il piano della rassegnazione. Se le piazze delle città sono vuote, sono tuttavia piene le piazzette dei paesi, i luoghi di incontro delle piccole comunità locali sono sempre più affollati. Questo aspetto rappresenta una sfiducia nei confronti dei partiti poiché tante persone e reti si industriano, si mobilitano, destinano il loro tempo ma dentro la cornice locale. Non vogliono avanzare di grado e non ritengono, riflette Filippo Barbera, che la propria competenza debba avere sbocchi nazionali. In questo scenario, emergono fenomeni nuovi, come l’eco ansia, in altri termini la consapevolezza che si è soli: non c’è lo Stato, come si è detto, e non è sufficiente la comunità organizzata. C’è la solitudine e, quindi, la paura. E l’ansia, nei confronti del clima che cambia e che produce collassi economici e, a cascata, collassi sociali. Ragioni molteplici, in definitiva, che rendono necessario progettare un futuro condiviso a partire dagli spazi della politica e dai luoghi di vita e di lavoro delle persone.

2) L’Italia vuota, Filippo Tantillo
Esperto in politiche pubbliche, del lavoro e dello sviluppo. Ricercatore presso Inapp (Istituto analisi politiche pubbliche) e Coordinatore scientifico Strategia Nazionale Aree Interne, Ministero della Coesione Territoriale. Componente il Comitato Scientifico di Cramars soc. coop.
ll libro L’Italia vuota è una sorta di diario di viaggio, una testimonianza da parte di chi ha vissuto le aree interne “da dentro”, come responsabile scientifico della Strategia Nazionale per le Aree Interne. Il libro racconta sette aree interne, riservando a ognuna un colore diverso: Smeraldo. Le valli occitane, Rosso. Il fiume Simeto, Verde. L’Appennino centrale, Argento. La costa ionica della Calabria, Grigio. Le Dolomiti orientali al centro d’Europa, Giallo. I confini mobili del Molise, Cenere. La Sardegna centrale. Non sono i sette colori primari (rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola e indaco), ma ci si avvicinano. Soprattutto, restituiscono con nitore, trasporto e visione l’idea che l’unica (e/o più importante) dimensione “nazionale” del Paese è la sua immensa diversità interna. Contro ogni discorso biecamente nazionalistico che blatera di “identità italiana” riconducendola a una tradizione inventata, per poi sorvolare sulla plastica evidenza che l’identità nazionale si mostra omogenea solo in occasione delle competizioni sportive o quando siamo chiusi dentro le gabbie di un discorso identitario a fini politici. La nostra diversità territoriale è ciò che ci rende simili. Migliaia di piccoli Comuni, poche grandi città, molte città medie, conurbazioni, coste, colline e montagne, aree interne, aree vaste dove città e campagna si tengono senza soluzione di continuità, sistemi territoriali bio-regionali. Territori diversi ma uniti dalla contrazione, demografica anzitutto, ma anche istituzionale, produttiva e di capacità di aspirare a un futuro collettivo. Territori artificialmente separati dai loro contesti, così come dai flussi e dagli scambi che li collegano a livelli di scala ulteriori. Le città non esisterebbero senza “l’hinterland”, così come la Pianura Padana non esisterebbe senza la funzione protettiva esercitata nel tempo dalle Alpi. Ma anche città medie come poli funzionali di un hinterland esteso, frange metropolitane del periurbano, continuum urbano-rurale: l’Italia di mezzo, come l’hanno chiamata Arturo Lanzani e collaboratori nei loro perspicaci lavori di mappatura del Paese (F. Curci, A. Kërçuku, A. Lanzani, F. Zanfi, “Italia di mezzo: The emerging marginality of intermediate territories between metropolises and inner areas”, Region, 10, 1, 2023, pp. 89-112). La varietà territoriale o policentrismo è il tratto unificante di un Paese unito dalla diversità. Tratto che coincide con la varietà dei bisogni e degli interessi delle persone-nei-luoghi, non solo con la diversità territoriale in senso geografico-morfologico. Senza la consapevolezza del policentrismo così inteso si ha solo spazio falsamente omogeneo, immobile e vuoto, da disciplinare con scelte “per la competitività” che, in realtà, privilegiano i centri. Il racconto di Tantillo, il suo diario di viaggio, è in chiaro-scuro. Nelle aree interne si concentrano e interagiscono diversi tipi di diseguaglianze: economiche (reddito e ricchezza), nell’accesso alle infrastrutture fondamentali della cittadinanza (trasporti, istruzione, servizi per la vita quotidiana), ma anche diseguaglianze di riconoscimento. Sono aree che hanno conosciuto processi di marginalizzazione e declino e che rappresentano un formidabile serbatoio di rabbia e risentimento, che si traduce spesso nel sostegno politico a forze populiste o nell’astensionismo. Si vota “con i piedi” (si emigra), ci si astiene o si vota chi promette la palingenesi anti-casta o il nativismo identitario. Aree dove i valori, le priorità, le regole pratiche e gli stili di vita di chi abita in quei luoghi non sono più riconosciuti dai modi “ordinari” di funzionamento delle istituzioni e, quindi, dalle classi dirigenti che governano i centri di potere, dal disegno delle politiche pubbliche e dalle regole che governano la distribuzione delle risorse. Non mancano, però, i chiari: il racconto-diario di Tantillo accende anche una luce di speranza. In queste aree si nascondo innovatori radicali, anche se spesso privi di potere. Cittadini, Sindaci, rappresentanti di associazioni, giovani innovatrici sociali. Ma anche risorse e beni comuni che costituiscono potenziali piattaforme abilitanti per nuovi modi di vivere e lavorare, così come di relazionarsi con quello che Bruno Latour in “Tracciare la rotta” ha definito il “terrestre”. Luoghi, dunque, prima che spazi. Scrive Bruno Latour che fino a prima della crisi climatica – e fino a quando il progetto della globalizzazione è stato sostenibile – ci si poteva riferire allo spazio come qualcosa al cui interno collocarsi anche solo tramite latitudine e longitudine. Le appartenenze locali erano derubricate a residui del passato, irrazionali o limitanti e, in quanto tali, da superare. Con la crisi climatica e con l’infrangersi del progetto globale assistiamo al ritorno del “terrestre”, dove i luoghi e i loro correlati tornano ad assumere importanza. L’attenzione si sposta così verso le persone-nei-luoghi, in direzione del policentrismo dei milieux locali, e chiama in causa l’intreccio tra dimensioni categoriali (classe, genere, etnia) e territoriali. Qui lo spazio non è l’intervallo tra le cose e le persone, il “contenitore che racchiude e separa” (A. Corboz, Avete detto spazio?, in Ordine sparso. Saggi sull’arte, il metodo, la città e il territorio, Franco Angeli, Milano 1998, pp. 227-233). Lo spazio dei luoghi rappresenta invece un campo “qualitativo”, “le cui proprietà sono definite sia dai suoi limiti sia dagli oggetti che in esso sono contenuti” (ivi, p. 230). Lo spazio assoluto rimanda alla concezione newtoniana formulata nei Principia mathematica: è assoluto in quanto esiste indipendentemente dai corpi materiali (esiste in sé, non è un sistema di relazioni fra corpi). Si tratta di uno spazio sostanziale, dotato di realtà, un contenitore vuoto, indifferente alla materia in esso contenuta e all’osservatore che in esso analizza i movimenti della materia. I luoghi narrati da Tantillo sono invece “associazioni” tra agenti e cicli naturali variamente combinati con attività umane, generatori di flussi, come quelli dei servizi ecosistemici, che si chiudono solo in parte nel sistema locale. Ne consegue che il “ritaglio” delle aree, le strategie di sviluppo, le interdipendenze tra le diverse misure, sono co-essenziali alle comunità di agency quali risultano dalle pratiche territoriali: gravitazioni su centri di servizi, mercati, reti, filiere produttive, legami funzionali, servizi ecosistemici, flussi di beni, servizi e persone. In molti casi ciò deve fare i conti con auto-rappresentazioni basate su identità storico-culturali reinterpretate e talvolta reinventate, ma non per questo meno importanti dal punto di vista dell’azione locale. Le sette aree costituiscono, poi, altrettanti esempi dell’importanza di valorizzare l’autonomia morale delle persone-nei-luoghi. L’Italia vuota testimonia come la diversità dei luoghi, e delle persone-nei-luoghi, non sia riconosciuta dal modo ordinario di funzionare delle istituzioni, dalle regole, priorità e “parole d’ordine” che guidano le politiche territoriali. Ciò può avvenire vuoi per un deficit di riconoscimento non necessariamente consapevole ma semplicemente frutto del cambiamento culturale, vuoi per un’azione intenzionale di misconoscimento che implica l’intenzione di escludere, vuoi per un atteggiamento paternalistico basato su politiche di compensazione che negano la capacità di agency dei luoghi (mi permetto di rimandare a F. Barbera, A. Zabatino, “Potere di riconoscimento, diseguaglianze territoriali e politiche pubbliche”, La Rivista delle Politiche Sociali, 2, 2022, pp. 17-32). Tracce di questo mancato riconoscimento si possono ascoltare nelle testimonianze dei vecchi e dei nuovi montanari esclusi dai sussidi che vanno alle grandi stazioni sciistiche, come nelle proteste dei Sindaci allo stremo nei numerosissimi piccoli Comuni di montagna e delle aree interne che vedono chiusi i servizi essenziali o nelle rimostranze dei produttori lattiero-caseari di montagna sottoposti alle medesime regole dei grandi caseifici di pianura. È per queste vie che il deficit di riconoscimento entra nella vita quotidiana delle persone, sospinto da regole, misure e politiche cieche ai luoghi che non contemplano bisogni, vincoli e priorità (materiali e simboliche) delle persone, imprese e istituzioni dei territori marginalizzati. Sordità alle esigenze specifiche (normative, fiscali, contrattuali, di sicurezza) delle micro-imprese delle aree interne e montane; dominanza di tecnologie che per prezzo, dimensioni ed esigenze di manutenzione escludono i bisogni della piccola agricoltura famigliare di montagna; o ancora rigidità delle regole che chiudono servizi pubblici (scuola, presidi sanitari, trasporti) in base a soglie demografiche disegnate sui parametri dei centri urbani e indifferenti alla contrazione delle aree del margine. Il ceto politico e la classe dirigente in generale – inclusi i dirigenti delle burocrazie ministeriali – guardano spesso dall’alto in basso questi territori e ostacolano le innovazioni istituzionali, come quella promossa dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne di cui l’autore è stato uno dei protagonisti. I centri e le loro strutture amministrative organizzate a “silos” sono lontanissimi dai bisogni delle persone nei luoghi marginalizzati. Problemi, questi, che tengono insieme le aree interne e le periferie urbane, le città medie e le campagne produttive, le coste e le aree collinari, all’insegna della contrazione della capacità collettiva di futuro che attanaglia il policentrismo territoriale italiano. L’Italia vuota parla così al suo doppio, l’Italia piena, per un’alleanza incentrata sui luoghi di vita e di lavoro delle persone.
3) I borghi della Calabria: dall’abbandono alla rinascita, Pierluigi Grandinetti, Daniele Chiriaco, Massimiliano Valle
Pierluigi Grandinetti, architetto friulano, è stato professore ordinario di composizione architettonica e urbana presso l’Università Iuav di Venezia ed ha sviluppato riflessioni e ricerche sulla centralità del progetto di architettura, sugli strumenti della sua composizione, sui rapporti tra composizione e costruzione e sulla progettazione architettonica del nuovo in rapporto alla conservazione dell’antico.
Il libro documenta i risultati della ricerca condotta diversità Iuav di Venezia sul tema “Architetture, borghi e paesaggi rurali” che ha indagato borghi calabresi in condizioni prevalenti di semiabbandono, del Reventino-Savuto: un anfiteatro naturale che si affaccia sul mar Tirreno, costituito dall’intorno del fiume Savuto e dalle pendici del monte Reventino. Tra i borghi analizzati: Conflenti Superiore, Cleto, Savuto, Grimaldi, San Mango d’Aquino, Scigliano, Amantea, Martirano e l’insediamento novecentesco di Martirano Lombardo. Il borgo rurale diventa così un nuovo ambito, conoscitivo e progettuale, di ricerca, per il quale è stato messo a punto un metodo di lavoro innovativo, utilizzabile in casi analoghi, basato sulla conoscenza del borgo per coglierne l’identità, a partire dai suoi principi architettonico-costruttivi, e sulla sua rigenerazione attraverso un “percorso di marketing territoriale”. In questo territorio è emersa la presenza di una costellazione di borghi di straordinario interesse, per la loro “unicità” nel rapporto ogni volta diverso tra i caratteri distintivi del borgo come architettura collettiva e testimonianza storica di cultura materiale, il paesaggio rurale in gran parte conservato che lo circonda, le produzioni agricole e i prodotti alimentari che lo caratterizzano, la vitalità della comunità che lo anima.

4) Lento Pede, Domenico Cersosimo e Sabina Licursi
Domenico Cersosimo, già professore di Economia applicata nell’Università della Calabria, è vicepresidente e membro del comitato direttivo dell’Associazione Riabitare l’Italia. Per Donzelli ha curato Contro i borghi (2022, con F. Barbera e A. De Rossi) e Manifesto per riabitare l’Italia (2020, con C. Donzelli). Sabina Licursi è professoressa associata di Sociologia generale presso l’Università della Calabria. Si occupa di solidarietà, homelessness, povertà educativa. È socia e componente del comitato direttivo dell’Associazione Riabitare l’Italia.
Le aree marginalizzate non sono spente. Per accorgersene però bisogna adottare altri sguardi, accendere i fari sulla vita che c’è nei paesi “vuoti”, sui bisogni, le attese e le aspirazioni di quanti restano, tornano e, più raramente, arrivano. Pochi, ma sufficienti per autorizzare la speranza che i luoghi rarefatti siano abitabili». È ancora possibile vivere nelle aree demograficamente rarefatte, con pochi bambini, sempre meno donne in età fertile, lavoro introvabile, tanti anziani e con una dotazione di servizi pubblici in contrazione? Si può abitare in comunità ormai rinsecchite, in paesi sempre più ostili al benvivere, nell’Italia fuori Italia, dove i diritti della Costituzione sono calpestati quotidianamente? Un’ampia ricerca empirica nella Calabria interna – l’estremo dell’Italia estrema – testimonia che in questi luoghi si continua ad abitare, a fare progetti, a manifestare bisogni, a sognare. C’è ancora vita. Ci sono famiglie con figli piccoli che hanno deciso di restare. Tanti giovani che hanno scelto di continuare a risiedervi e tanti altri che resterebbero se si creassero le condizioni per fermarsi. E soprattutto ci sono anziani, il più delle volte soli, che restano perché da sempre radicati in quelle terre e che mantengono vive relazioni sociali di prossimità e minute economie. Si può aspirare a un futuro diverso da quello contratto e cupo delle tendenze demografiche e dell’indifferenza istituzionale, se si rovesciano i vincoli in opportunità: la rarefazione demografica come alternativa alla congestione urbana; la lentezza come guadagno di tempo per abitare lo spazio; le pluriclassi per mettere a punto nuovi metodi didattici; la distanza dai poli di servizi per sviluppare forme di mobilità e accessibilità diverse, diagnostica innovativa e cure mediche adeguate. Serve uno sguardo partigiano per riconoscere i cittadini che hanno scelto di restare, la loro voglia di continuare a vivere in contesti appartati, diversamente appaganti. Serve dare potere decisionale e assicurare la rappresentanza politica ai residenti. Serve il coraggio delle sperimentazioni per porre domande alla società intera, perché sostenere la qualificazione della vita in aree rarefatte significa anche rendere meno fragile la ricchezza nelle aree dense. Servono politiche dal basso e dall’alto per far diventare strategie, progetti, azioni le visioni di futuro che – come gli acini dell’uva puttanella – maturano anche in questi luoghi.